Ai dark di tutto il mondo non
sarà mai abbastanza chiaro, quindi non verrà ripetuto mai abbastanza
spesso, quanto non solo tutta la new wave, ma anche tutto il rock
gotico nasceranno dalle sperimentazioni sonore di due grandissimi:
David Bowie e Brian Eno.
Per quanto riguarda la new wave in senso lato ci si riferisce al Bowie
da Ziggy Stardust in poi, fino a quel Young
Americans che segnò un’apparente (ma per fortuna momentanea)
perdita di vena poetica. Ed al Brian Eno dal periodo Roxy Music alle
prime prove soliste, almeno fino a quel capolavoro che è stato Before
and After Science (1977). Per quanto riguarda il dark, invece,
ci si riferisce alla cosiddetta Trilogia Berlinese, il vero evento
ispiratore di tutta la scena gotica, ombra scura che aleggiava su
tutte le sperimentazioni musicali in corso dal ‘78 in poi.
 David
Bowie è stato senz’altro un caso più unico che raro nella storia
del rock. Dopo aver composto (e pubblicato!) dal 1966 in poi abbastanza
materiale da riempire abbondantemente due o tre Lp, e non aver ottenuto
nessunissimo riscontro da parte di pubblico e critica, finalmente
nel ‘70 mette a segno un colpaccio: la bellissima Space Oddity,
che gli dà un improvviso ed imprevedibile successo internazionale.
Per un altro paio d’album combina poco e sarà con l’audace
Hunky Dory (1971) che comincerà sul serio una sorprendente
carriera. Seguirà Ziggy Stardust, ovvero la musica
(e la star) che parla di se stessa e del suo mercato, ed Aladdin
Sane, il genio, l’esistenzialismo e l’eroina. Con
questi 3 album Bowie diventa in assoluto il re di certo pop-rock tra
ambiguità, glam e moderata sperimentazione. Un disco azzeccatissimo
di cover come Pin-ups non fa altro che rafforzarne
il mito.
David
Bowie è stato senz’altro un caso più unico che raro nella storia
del rock. Dopo aver composto (e pubblicato!) dal 1966 in poi abbastanza
materiale da riempire abbondantemente due o tre Lp, e non aver ottenuto
nessunissimo riscontro da parte di pubblico e critica, finalmente
nel ‘70 mette a segno un colpaccio: la bellissima Space Oddity,
che gli dà un improvviso ed imprevedibile successo internazionale.
Per un altro paio d’album combina poco e sarà con l’audace
Hunky Dory (1971) che comincerà sul serio una sorprendente
carriera. Seguirà Ziggy Stardust, ovvero la musica
(e la star) che parla di se stessa e del suo mercato, ed Aladdin
Sane, il genio, l’esistenzialismo e l’eroina. Con
questi 3 album Bowie diventa in assoluto il re di certo pop-rock tra
ambiguità, glam e moderata sperimentazione. Un disco azzeccatissimo
di cover come Pin-ups non fa altro che rafforzarne
il mito.
A questo punto un evento che merita tutta la nostra attenzione. Il
disco successivo, quel geniale Diamond Dogs così
capace di recuperare, reinterpretandola, certa tradizione sanguigna
blues ed hard rock, fu definito da Bowie stesso come “gotico”.
È la prima volta che una cosa simile accade. Da allora in poi “gotico”
sarà una delle tante categorie che permetteranno ai critici di definire
la musica. Correva l’anno 1974.
Bowie purtroppo, dopo anni di genio e successi, non riuscì a resistere
alla tentazione di un po’ di gigionesca faciloneria, ed uscì
con un disco come Young Americans, col quale cominciò
la sua collaborazione col chitarrista Carlos Alomar. Più o meno apprezzato
dal pubblico, ma certamente infamato e deriso da certa critica, fu
Bowie stesso a rendersi conto della necessità di cambiare rotta. Veniva
accusato di superficialità e faciloneria? La soluzione sarebbe stata
nel senso di una più profonda ricerca musicale. In effetti la “musica”
in senso stretto non era mai stata una specialità di Bowie, molto
più incentrato sul songwriting o tutt’al più su soluzioni più
o meno innovative negli arrangiamenti. La risposta era contenuta nel
disco del ‘76: Station to Station.
In effetti Station to Station  è
un vero punto di svolta nella sua carriera. Il primo brano, omonimo,
oltre al tono serio e colto, aveva una struttura decisamente complessa
per una durata di ben 10 minuti! Chiaramente non potevano essere tutti
cantati e finalmente il musicista prendeva il posto del (geniale)
menestrello ambiguo e glamorous. Anche gli altri 5 brani erano decisamente
lunghi, cioè con una durata media di circa 6 minuti. Un assurdo, all’infuori
dei ben definiti territori del progressive rock (per altro già morente:
non dimentichiamoci che il ‘76 è stato il primo anno del punk).
La mossa azzeccata e la consapevolezza dei suoi limiti, oltre che
una serie di casi fortuiti, portò il nostro a incontrare e, conseguentemente,
cercare la collaborazione con il genio
è
un vero punto di svolta nella sua carriera. Il primo brano, omonimo,
oltre al tono serio e colto, aveva una struttura decisamente complessa
per una durata di ben 10 minuti! Chiaramente non potevano essere tutti
cantati e finalmente il musicista prendeva il posto del (geniale)
menestrello ambiguo e glamorous. Anche gli altri 5 brani erano decisamente
lunghi, cioè con una durata media di circa 6 minuti. Un assurdo, all’infuori
dei ben definiti territori del progressive rock (per altro già morente:
non dimentichiamoci che il ‘76 è stato il primo anno del punk).
La mossa azzeccata e la consapevolezza dei suoi limiti, oltre che
una serie di casi fortuiti, portò il nostro a incontrare e, conseguentemente,
cercare la collaborazione con il genio  musicale
degli anni 70: Brian Eno, l’inventore del rock elettronico e
futurista prima, dell’ambient music e di certa “etno-tronica”
dopo. E raramente incontro si potrà definire più appropriato ed auspicabile.
musicale
degli anni 70: Brian Eno, l’inventore del rock elettronico e
futurista prima, dell’ambient music e di certa “etno-tronica”
dopo. E raramente incontro si potrà definire più appropriato ed auspicabile.
Trovatisi con il produttore Tony Visconti, storico collaboratore di
Bowie, i due si misero a registrare le prime tracce in Francia, più
esattamente al Château d’Hérouville, accompagnati da musicisti
del calibro di Carlos Alomar e Ricky Gardener alle chitarre, George
Murray al basso, Dennis Davis alla batteria (tutti provenienti, almeno,
da Station to Station), Roy Young alle tastiere e
(addirittura) Iggy Pop alla seconda voce! Ma la scintilla artistica
era partita e così il nichilismo depresso del punk stava contagiando
anche loro. Il bel castello classico francese non dava abbastanza
suggestioni in questo senso, si imponeva una scelta coraggiosa: entrare
nel cuore marcio e negativo dell’Europa. Quale città migliore
della divisa e torbida Berlino?
Finite le registrazioni ed il missaggio all’Hansa presso il Muro,
lo studio di registrazione berlinese dell’Ariola Hansa, prima
casa discografica dei Japan, il risultato uscito nel gennaio del ‘77
fu lo sconvolgente Low.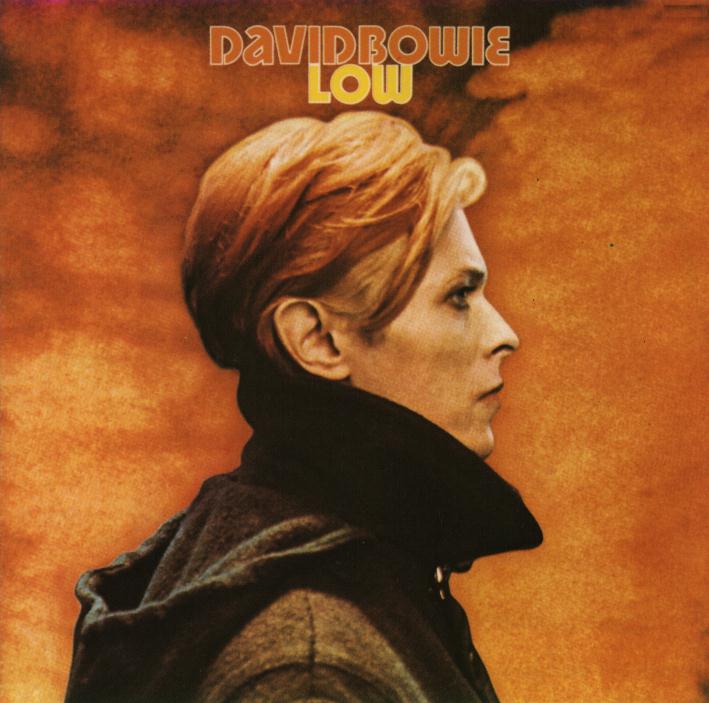
Sin dal primo strumentale, la dinamica e danzereccia Speed of Life,
con quella sua pazzesca scala discendente di sintetizzatore, ci si
rende conto di essere davanti ad un prodotto assolutamente diverso
da tutta la discografia Bowiana. Per carità, quest’idea passa
con la successiva Breaking Glass, pezzo già molto più in linea
con la vena (seppur varia e fantasiosa) del nostro, così come tutto
il lato A dell’album, con i due capolavori Always Crashing
in the Same Car e Sound and Vision, quest’ultima singolo
di grande successo. Certo, c’era un elemento innovativo, strano
e straniante: gli arrangiamenti erano molto più complessi e ricercati
del solito, più tecnocratici, e le parti strumentali molto più lunghe
ed importanti. Insomma, la mano del genio Eno si faceva pesantemente
sentire.
Ma fu soprattutto la b-side a lasciare i vecchi fan esterrefatti e
basiti. Il lato di un disco di Bowie, il primo, interamente ed esclusivamente
composto di brani strumentali! Un inizio soffuso ed intimo per A
New Career in a New Town, che poi esplode in una melodia dinamica
e percussiva per dominante di armonica a bocca. Una partitura futurista,
ma energica ed allegra, in forte contrasto con il brano che la seguirà:
Warszawa, sin dalle prime note di un piano virato e decadente,
sarà uno dei capolavori della depressione cosmica del duo Bowie-Eno.
Un’atmosfera d’una solennità quasi sovietica, per piano
e flauto più o meno sintetizzati, che per più di sei minuti declamano
i loro rintocchi in una desolazione che è nel contempo amarezza e
profondità, elevazione dell’anima. L’aria in sé potrebbe,
talvolta, anche esprimere una certa speranza quasi gioiosa, prima
che la solennità dei ghiacci e dei cori lugubri la faccia tornare
al suo posto. Un salmodiare etnico fa da stridente contrappunto sul
finale di quest’opera tanto modernista quanto profetica.
Un’atmosfera non molto dissimile contraddistingue la successiva
Art Decade, nonostante il soffuso inizio percussivo. Sarà una
tastiera esistenzialista e depressa a prendere il sopravvento, con
effettini elettronici di sottofondo che non faranno scordare il genio
e l’impressionante modernità dei compositori. Un’opera senza
tempo. Weeping Wall è un assurdo muro del pianto cinese, con
chitarra trattata e distorta tra i campanellini psichedelici ma fermi
e gli inserti di una tastiera altrettanto statica. Una voce talvolta
fa capolino in un’atmosfera che, sebbene meno depressa delle
due precedenti, è sempre strana e compressa, senza mai comunque diventare
claustrofobica, anche se molto inquietante. Subterraneans è
il degno finale dell’album. Un altro strumentale solenne e depresso,
con inserti tastieristico-sperimental-elettronici, anche se stavolta
le partiture si rifanno ad un’aria più classicheggiante. L’ingresso
del coro lugubre dona al tutto un mood ancora più straniante: depresso
eppur “aperto”, in qualche modo “arioso”, con
inserto di sassofono che anticipa una sorta di canto tra il mantrico
ed il malinconico su testo simbolico o nonsense. Il tutto andrà lentamente
spegnendosi.
L’impatto di Low
su pubblico e critica fu tale che i due responsabili non poterono
non risultarne quantomeno lusingati. Nell’anno della morte del
rock (ucciso dal punk), i due maggiori avanguardisti avevano composto
uno dei maggiori capolavori della lror carriera. Il tempo era propizio,
l’atmosfera berlinese pure, i due si rimisero subito al lavoro,
mantenendo Alomar, Davis e Murray, ma sostituendo Gardener con un
chitarrista d’eccezione: Robert Fripp, il deus-ex-machina dei
King Crimson. L’Hansa presso il Muro di Berlino manovrato da
Tony Visconti furono altri due elementi insostituibili.
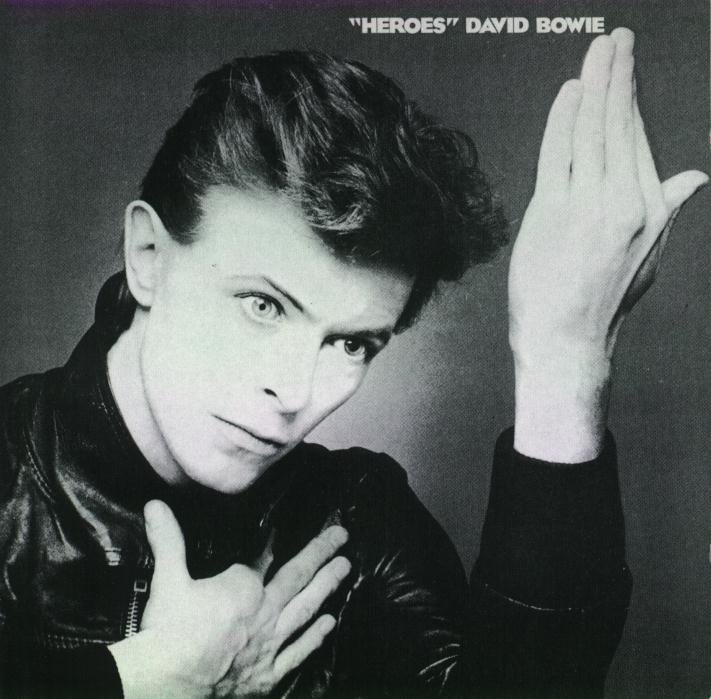 Il risultato, uscito nell'ottobre di quel 1977,
fu l’ormai celeberrimo Heroes, uno degli album
di Bowie in assoluto più venduti. La formula ricalcava in qualche
modo quella di Low, sebbene con qualche variante.
Innanzitutto l’inizio non veniva affidato ad uno strumentale,
ma alla bella e fragorosa Beauty and the Beast. Inutile poi
star qui a ricordare o descrivere i celeberrimi successi che sono
stati (e hanno conosciuto) brani come Joe the Lion ma soprattutto
la title-track, quella “Heroes” portata al successo
dal film Chistiane F (noi i ragazzi dello zoo di Berlino).
Il risultato, uscito nell'ottobre di quel 1977,
fu l’ormai celeberrimo Heroes, uno degli album
di Bowie in assoluto più venduti. La formula ricalcava in qualche
modo quella di Low, sebbene con qualche variante.
Innanzitutto l’inizio non veniva affidato ad uno strumentale,
ma alla bella e fragorosa Beauty and the Beast. Inutile poi
star qui a ricordare o descrivere i celeberrimi successi che sono
stati (e hanno conosciuto) brani come Joe the Lion ma soprattutto
la title-track, quella “Heroes” portata al successo
dal film Chistiane F (noi i ragazzi dello zoo di Berlino).
Sons of the Silent Age era un pezzo intimo ma anch’esso
tipicamente bowiano, seguito dalla più dinamica e scatenata Blackout,
che chiudeva in bellezza la a-side. Girato l’Lp, la sorpresa-non-sorpresa
della struttura di Low: una parte quasi interamente
strumentale. La prima V-2 Schneider, nonostante l’inizio
solenne, si risolverà in una specie di rock-boogie tecnocratico, stranamente
simile a certe soluzioni dei Kraftwerk più allegri ed ottimisti. Similmente
a A New Career in a New Town fu l’allegra tempesta prima
della mortifera quiete.
Trattatasi, nel dettaglio, di una lunga suite musicale divisa in tre
movimenti. Il primo, Sense of Doubt (già inquietante dal titolo)
cominciava con un vento sintetico che diventava sottofondo ad una
scala lugubre di piano. Una sorta di tastiera-tromba sintetizzata
declamava una meditativa melodia su sfondo di effetti elettronici,
prima del ritorno fragoroso del piano e della successiva partitura
d’organo. Un pezzo dalla maestosità agghiacciante. Il cui stesso
vento, tramite sinterizzazioni successive, ci porterà all’arpeggio
d’apertura della successiva Moss Garden, dove orientali
strumenti a corda svetteranno su tappeti di tastiera tecnologico-psichedelici.
Quasi 4 minuti di un oriente mistico e opprimente insieme, dolcissimo
e minaccioso. Rumorini della natura ed il vento sintetico-postatomico
introducono alla successiva ed europeissima Neuköln, dove una
tastiera funerea ed opprimente, non troppo diversa da un’atmosfera
già respirata in Warszawa, viene appena mitigata da un sassofono
solitario e straziante. Il risultato è una sinfonia allucinata per
ghiacci e spazi bui, per architetture gotiche e tristezze cosmiche,
per una sconfinata e disperata decadenza che la sua stessa lamentosa
consapevolezza non può risolvere.
La finale, cantata, allegra e scanzonata The Secret Life of Arabia
toglierà l’oppressivo senso di profonda angoscia inevitabilmente
insinuatosi nell’animo dell’ascoltatore. Al contrario di
Low, Heroes finisce in modo più
rilassato.
Ma nel frattempo il 1978 avrà
avuto inizio ed una nuova generazione di musicisti andava formandosi.
I due capolavori Low ed Heroes osservavano
dall’alto, oscure eminenze grigie, influenzando silenziosamente
e nell’ombra una scena musicale in formazione. I due geni Bowie
ed Eno si prenderanno entrambi una pausa di riflessione l’uno
dall’altro, il primo impegnato in una lunga e proficua tournée,
l’altro in produzioni varie, tra le quali quella della fortunata
ed illuminante compilation No New York.
I due si ritrovarono alla fine del ‘78, consapevoli di aver influenzato
notevolmente la scena musicale inglese (ed internazionale) ed intenzionati
ad andare avanti ed oltre. Qualcosa di diverso però stava insinuandosi:
è ovvio, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, figuriamoci
tre! La squadra fu quasi interamente ricomposta: Alomar alla chitarra,
Murray al basso, Davis alla batteria e Visconti al mixer, ma il contatto
con lo studio Hansa di Berlino non venne riconfermato. Fu così che
un po’ cervelloticamente il nuovo disco fu registrato a Montreaux,
in Svizzera e, per motivi legati ai loro recenti impegni, mixato a
New York. Ma la squadra, le menti e le intenzioni erano quelle, di
conseguenza questo fu considerato il terzo capitolo della Trilogia
Berlinese.
Tutti si aspettavano da Lodger,
uscito nel corso del ‘79, un altro, forse estremo disco dark.
Ma Bowie e soprattutto Eno erano di mentalità troppo proiettata al
futuro per ripetersi e  cercarono invece di prevedere la prossima evoluzione
della scena musicale d’avanguardia. Inutile dire che ci riuscirono
perfettamente, nel segno di una ricerca etnica che, grazie prima ai
Japan e David Sylvian, poi ad un maturo Peter Gabriel, sfocerà nella
grande corrente di musica etnica che fiorirà verso la fine degli anni
80. Ne segue che Lodger è il titolo della trilogia
che a noi interessa meno, nonostante la sua ragguardevole caratura
artistica: mai un’atmosfera particolarmente notturna, definitivamente
scomparso ogni strumentale, a maggior ragione i loro capolavori di
depressione. Giusto l’ultima Red Money conserverà una
lontana inquietudine.
cercarono invece di prevedere la prossima evoluzione
della scena musicale d’avanguardia. Inutile dire che ci riuscirono
perfettamente, nel segno di una ricerca etnica che, grazie prima ai
Japan e David Sylvian, poi ad un maturo Peter Gabriel, sfocerà nella
grande corrente di musica etnica che fiorirà verso la fine degli anni
80. Ne segue che Lodger è il titolo della trilogia
che a noi interessa meno, nonostante la sua ragguardevole caratura
artistica: mai un’atmosfera particolarmente notturna, definitivamente
scomparso ogni strumentale, a maggior ragione i loro capolavori di
depressione. Giusto l’ultima Red Money conserverà una
lontana inquietudine.
Bowie era tornato se stesso: l’androgino ed ambiguo re del glam
rock, solo più maturo e, se possibile, ancora più all’avanguardia.
Certo, un’avanguardia cui basteranno l’abbandono di Eno
ed ancora pochi anni per essere perduta, definitivamente con Let’s
Dance.
Ma intanto il suo segno l’aveva lasciato. Con Young Americans
sembrava un artista sull’orlo della fine (a molti capita che
dopo 3-4 buoni dischi la vena vada perduta), con la scoperta delle
malinconiche e solenni atmosfere mitteleuropee era risorto a nuova
vita. Ed ancora una volta la sua arte servì d’ispirazione a molti.
Noi lo sappiamo bene.
indice - avanti

