Il mainstream, il
"flusso principale", quel genere dalle dolci melodie e dalle
strutture rassicuranti, dal rock melodico della west coast (Eagles,
Journey, Toto) a cose anche più politicamente impegnate (Bruce Springsteen),
dai cantautori fino a veri e propri compromessi con il pop (il c.d.
AOR o roccuccio da classifica). Eppure, tra la fine dei sessanta e
l’inizio dei settanta, anche il mainstream produsse le sue perle
oscure, per opera della “trimurti” dei cantautori apocalittici:
Leonard Cohen, Nick Drake e Tim Buckley. Cantautori, sì, e pure melodici,
ma dalla depressione tanto disperata quanto funerea.
Il primo e forse il maggiore di tutti, di sicuro il più lucido fu,
anzi è Leonard Cohen. Ebreo canadese, poeta, personaggio incredibilmente
schivo. A quarant’anni decide di mettere in musica alcune sue
poesie: lo fa in modo semplice, voce e chitarra, rari altri accompagnamenti,
solo occasionali voci femminili aggiunte.
 L’album
risultante, Songs of Leonard Cohen, del 1966, è un incredibile capolavoro.
Melodie delicatissime e toccanti, sarebbe meglio dire strazianti,
ma senza mai una traccia di lamentela o autocommiserazione. In compenso,
però, un pessimismo nero e depresso che impregna ogni cosa. La prima,
Suzanne, forse il capolavoro di Cohen, parla di una donna matta
eppur desiderata, di.un desiderio represso ed inconfessabile (you
touched her perfect body with your mind), accompagnato da lirica e
dolcissima depressione,
L’album
risultante, Songs of Leonard Cohen, del 1966, è un incredibile capolavoro.
Melodie delicatissime e toccanti, sarebbe meglio dire strazianti,
ma senza mai una traccia di lamentela o autocommiserazione. In compenso,
però, un pessimismo nero e depresso che impregna ogni cosa. La prima,
Suzanne, forse il capolavoro di Cohen, parla di una donna matta
eppur desiderata, di.un desiderio represso ed inconfessabile (you
touched her perfect body with your mind), accompagnato da lirica e
dolcissima depressione,  così come la lunga ed ipnotica The Stranger
Song. O ancora l’altrettanto lunga e commovente Sisters
of Mercy (nessun riferimento è casuale), dove viene mantenuta
fino in fondo l’ambiguità del nome, che può definire un ordine
religioso o in genere le prostitute. Più allegra ed arrangiata, So
Long Marianne precede l’altro capolavoro di depressa dolcezza
Hey, That’s no Way to Say Goodbye e l’anima sprofonda
fra pieghe segrete. L’autobiografica (come tutte, del resto)
Teachers contiene il famoso verso «some girls wander by mistake».
così come la lunga ed ipnotica The Stranger
Song. O ancora l’altrettanto lunga e commovente Sisters
of Mercy (nessun riferimento è casuale), dove viene mantenuta
fino in fondo l’ambiguità del nome, che può definire un ordine
religioso o in genere le prostitute. Più allegra ed arrangiata, So
Long Marianne precede l’altro capolavoro di depressa dolcezza
Hey, That’s no Way to Say Goodbye e l’anima sprofonda
fra pieghe segrete. L’autobiografica (come tutte, del resto)
Teachers contiene il famoso verso «some girls wander by mistake».
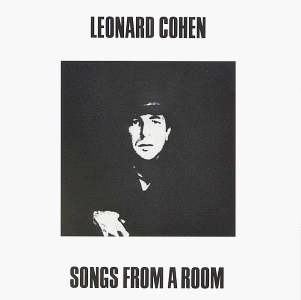 Piacevolmente sorpreso dall’insospettabile
successo internazionale del disco, tuttavia non più disposto di prima
a “darsi in pasto” a media e mondanità, Cohen ripeté la
stessa formula un anno dopo, dando alle stampe l’immortale Songs
from a Room. In effetti la formula è proprio la stessa (i due sono,
a tutti gli effetti, dischi gemelli), con aggiunta di spartanità per
la copertina in bianco e nero e di un’ulteriore dose di depressione.
Quello che purtroppo sembra mancare è l’incantevole magia delle
melodie, qui non meravigliosamente riuscite come nel titolo precedente.
Tuttavia non mancano i capolavori: una versione devastante di The
Partisan (con canto femminile in francese, da pelle d’oca),
unico brano non suo, lo sberleffo libertario di Bird on the Wire,
l’angoscia allucinante di Story of Isaac (il sacrificio
più famoso della Bibbia raccontato con gli occhi della vittima), la
pacata invettiva interpersonale di You Know Who I Am.
Piacevolmente sorpreso dall’insospettabile
successo internazionale del disco, tuttavia non più disposto di prima
a “darsi in pasto” a media e mondanità, Cohen ripeté la
stessa formula un anno dopo, dando alle stampe l’immortale Songs
from a Room. In effetti la formula è proprio la stessa (i due sono,
a tutti gli effetti, dischi gemelli), con aggiunta di spartanità per
la copertina in bianco e nero e di un’ulteriore dose di depressione.
Quello che purtroppo sembra mancare è l’incantevole magia delle
melodie, qui non meravigliosamente riuscite come nel titolo precedente.
Tuttavia non mancano i capolavori: una versione devastante di The
Partisan (con canto femminile in francese, da pelle d’oca),
unico brano non suo, lo sberleffo libertario di Bird on the Wire,
l’angoscia allucinante di Story of Isaac (il sacrificio
più famoso della Bibbia raccontato con gli occhi della vittima), la
pacata invettiva interpersonale di You Know Who I Am.
Il successo internazionale lo spaventò un poco e lo convinse ad allontanarsi
dalle scene. Da allora i suoi dischi furono sempre più rari e tuttavia
non sempre ugualmente ispirati. Troppo politicizzato, ad esempio,
appare il successivo Songs of Love and Hate, del ‘71, con canzoni
molto lunghe e forse anche un peletto pretenziose. Tuttavia ci sono
due suoi capolavori assoluti: Famous Blue Raincoat (in grado
di gareggiare con Suzanne) e Joan of Arc (un altro sacrificio,
stavolta pubblico e, più che visto, trasfigurato dalla vittima), per
non parlare della sadomasochistica Avalanche che tanto piacerà
a Nick Cave.
 Dopo il sentito live di rito, del
‘73, più convincente risulterà essere l’anno dopo New Skin
for the Old Ceremony. Le melodie si aprono ad atmosfere più aeree,
anche gli arrangiamenti risultano leggermente più vari. L’angoscia
di una vita di coppia vista come casa abitata da fantasmi in Is
This What you Wanted, ancora dolcezza dei primi tempi con Chelsea
Hotel #2, nuova energia con Lover Lover Lover, poi l’(auto)ironica
Field Commander Cohen, infine le bellissime There is a War
e Who by Fire. Copertina alchemica, melodie gaeliche, testi
importanti, una voce che cominciava a scaldarsi e che, con gli anni,
avrebbe portato Cohen ad interpretare le tonalità più basse e profonde
del cantautorato internazionale.
Dopo il sentito live di rito, del
‘73, più convincente risulterà essere l’anno dopo New Skin
for the Old Ceremony. Le melodie si aprono ad atmosfere più aeree,
anche gli arrangiamenti risultano leggermente più vari. L’angoscia
di una vita di coppia vista come casa abitata da fantasmi in Is
This What you Wanted, ancora dolcezza dei primi tempi con Chelsea
Hotel #2, nuova energia con Lover Lover Lover, poi l’(auto)ironica
Field Commander Cohen, infine le bellissime There is a War
e Who by Fire. Copertina alchemica, melodie gaeliche, testi
importanti, una voce che cominciava a scaldarsi e che, con gli anni,
avrebbe portato Cohen ad interpretare le tonalità più basse e profonde
del cantautorato internazionale.
Successivamente la vena sembrò abbandonarlo. Una brutta storia con
Scientology, pochi dischi, due per l’esattezza, molto brutti:
Death of a Lady’s Man e Recent Songs. Tornerà ad ottimi livelli
solo nel 1984, con Various Positions, leggermente più compromesso
con le melodie dominanti, quindi decisamente meno depresso. A quanto
risulta è tuttora attivo: il suo ultimo disco, Ten New Songs, è del
2001. È stato uno dei massimi cantautori americani, creatore delle
melodie più toccanti e depresse e dei testi più poetici (ed intelligenti).
Tuttavia ha fallito miseramente ogni volta che ha creduto toppo in
se stesso, ovvero quando troppo si amava o prendeva sul serio.
Caratterialmente (e melodicamente)
simile, ma  dalla
personalità molto più fragile, Nick Drake fu autore di tre bellissimi
dischi fra il ‘69 ed il ‘72. Inglese, nato a Burma, studentello
a Cambridge, con il primo Lp, Five Leaves Left, si inserì nel filone
allora di grido del folk revival. Le sue carte emergono sin da subito,
in tutto il loro splendore: una voce tenue e delicata, ma incredibilmente
matura, a comporre acquarelli intimi e fatalisti. Spesso una disincantata
depressione fa capolino tra queste perle diafane, rendendole vibranti
fino ai brividi. È il caso di Three Hours o di Cello Song,
dalla
personalità molto più fragile, Nick Drake fu autore di tre bellissimi
dischi fra il ‘69 ed il ‘72. Inglese, nato a Burma, studentello
a Cambridge, con il primo Lp, Five Leaves Left, si inserì nel filone
allora di grido del folk revival. Le sue carte emergono sin da subito,
in tutto il loro splendore: una voce tenue e delicata, ma incredibilmente
matura, a comporre acquarelli intimi e fatalisti. Spesso una disincantata
depressione fa capolino tra queste perle diafane, rendendole vibranti
fino ai brividi. È il caso di Three Hours o di Cello Song,
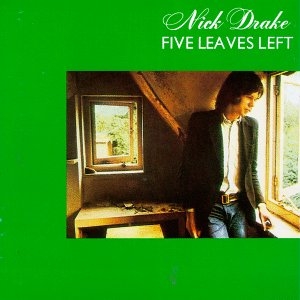 mentre brani come Way to Blue o Fruit
Tree mettono in luce addirittura una sorta di pessimismo cosmico,
alla Tim Buckley. Un caso a parte lo costituisce la splendida River
Man, trascendente e psichica, cosmica ed onirica fino all’alienazione.
mentre brani come Way to Blue o Fruit
Tree mettono in luce addirittura una sorta di pessimismo cosmico,
alla Tim Buckley. Un caso a parte lo costituisce la splendida River
Man, trascendente e psichica, cosmica ed onirica fino all’alienazione.
L’album dopo, purtroppo, fu il frutto delle pressioni dei produttori.
Bryter Lyter (1970), infatti, contiene troppe canzoni “solari”
e troppi arrangiamenti jazzati, caratteristiche che tendono a tradire
(e contraddire, se non addirittura a sovvertire) la delicata intimità
dei suoi brani. Fortunatamente non mancano felici eccezioni, che impreziosiscono
un disco altrimenti da trascurare. La terza, ad esempio, At the
Chime of the City Clock ha una bellissima strofa base intima e
avvolgente (la voce di Drake è comunque ancora più calda e matura
di prima), tuttavia un ritornello troppo melodico la rovina un po’.
Molto meglio la successiva One of these Things First, dalla
lievissima depressione quasi sognante, quasi adolescenziale, similmente
alla successiva Hazey Jane 1. Dopo la strumentale title-track
fa capolino la bellissima Fly, paragonabile alle sue prime
cose. Successivamente sarà la penultima Northern Sky a dare
momenti di introspezione triste ma mai autoindulgente.
 Poi qualcosa successe nella vita di Nick Drake.
Un travaglio esistenziale devastante, che l’ha portato sull’orlo
di una depressione senza ritorno. Molte canzoni, brevissime, furono
composto in questo periodo; quasi non arrangiate, giusto una chitarra
classica ed un piano. Undici di queste andarono a comporre il suo
ultimo album, il breve Pink Moon, del ’72. Sono i brani più scarni
e belli del genere a comporre questo capolavoro di depressione cosmica:
la title-track, Road, Which Will, Know, Parasite.
Ballate catatoniche ed attonite, di una dolcezza struggente, di un
pessimismo sconsolato e schiacciante. Fino alla “parabola terrificante
sulla solitudine in mezzo alla folla” (così lo Scaruffi) di Things
Behind the Sun, dove il punto di non ritorno viene ampi
Poi qualcosa successe nella vita di Nick Drake.
Un travaglio esistenziale devastante, che l’ha portato sull’orlo
di una depressione senza ritorno. Molte canzoni, brevissime, furono
composto in questo periodo; quasi non arrangiate, giusto una chitarra
classica ed un piano. Undici di queste andarono a comporre il suo
ultimo album, il breve Pink Moon, del ’72. Sono i brani più scarni
e belli del genere a comporre questo capolavoro di depressione cosmica:
la title-track, Road, Which Will, Know, Parasite.
Ballate catatoniche ed attonite, di una dolcezza struggente, di un
pessimismo sconsolato e schiacciante. Fino alla “parabola terrificante
sulla solitudine in mezzo alla folla” (così lo Scaruffi) di Things
Behind the Sun, dove il punto di non ritorno viene ampi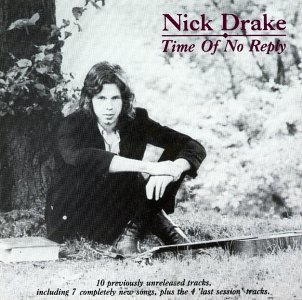 amente superato.
amente superato.
Infatti poco dopo seguirà il suicidio del cantante (o morte accidentale
per eccessiva assunzione di anti-depressivi, come recita la versione
ufficiale dei fatti), nel ’74 per la precisione, fra l’indifferenza
o al più l’incomprensione generale. Aveva 26 anni. Il rimanente
del suo funereo repertorio fu pubblicato nell’87 sull’Lp
Time of No Reply, un disco forse ancora più bello e spettrale di Pink
Moon (tra le perle la title-track, Clothes of Sand e Black
Eyed Dog). A testimonianza di un genio incompreso di proporzioni
titaniche, forse il primo vero autore di apocalyptic folk, sebbene
sempre in chiave intima, appena lievemente romantica e strettamente
personale.
Dal più fragile dei tre al
miglior musicista e cantante. Partito, in realtà, in linea con gli
altri due, con il primo omonimo album Tim Buckley si dimostrò un folksinger
di maniera. Decisamente meglio il secondo, Goodbye and Hello del 1967
(Tim aveva appena vent’anni) che, oltre alla scoperta di tastiere
e percussioni, annovera tra i capolavori del genere.
 Originario di Washington
ma presto trasferitosi prima a New York, poi a Los Angeles,
questo ragazzone timido, schivo ed estremamente sensibile (quasi alla
nevrosi) trasferiva su disco le mille sfumature della sua psiche,
aiutato dal poeta Larry Beckett che scrisse per lui alcuni dei suoi
capolavori. Tra queste cominciò ad affiorare certa malinconia, a tratti
anche depressa, soprattutto in bellissime e delicatissime canzoni
come Carnival Song, tempestata di organetti fieristici o Hallucinations
decorata di lontani e stordenti effetti psichici. Ma i capolavori
non sono finiti: Once I Was, ballata country con armonica delicata
fino all’ossessione o la meravigliosa canzone d’amore Phantasmagoria
in Two, dal ritmo vivace ma dalla voce straziante. La riservatezza
maestosa di Morning Glory chiude un album quantomeno rivelatore.
Originario di Washington
ma presto trasferitosi prima a New York, poi a Los Angeles,
questo ragazzone timido, schivo ed estremamente sensibile (quasi alla
nevrosi) trasferiva su disco le mille sfumature della sua psiche,
aiutato dal poeta Larry Beckett che scrisse per lui alcuni dei suoi
capolavori. Tra queste cominciò ad affiorare certa malinconia, a tratti
anche depressa, soprattutto in bellissime e delicatissime canzoni
come Carnival Song, tempestata di organetti fieristici o Hallucinations
decorata di lontani e stordenti effetti psichici. Ma i capolavori
non sono finiti: Once I Was, ballata country con armonica delicata
fino all’ossessione o la meravigliosa canzone d’amore Phantasmagoria
in Two, dal ritmo vivace ma dalla voce straziante. La riservatezza
maestosa di Morning Glory chiude un album quantomeno rivelatore.
Il successivo Happy Sad (1968), il primo senza Beckett, testimonia
di un  personaggio
selvaggiamente preda delle droghe. Le canzoni, ora solo sei, mantengono
più o meno la struttura tradizionale (country), ma gli arrangiamenti
si fanno più audaci e jazzati e due brani superano addirittura la
soglia dei 10 minuti. Anche la voce è diversa: ora sono gli shouter
neri i suoi maestri e Tim dimostra delle qualità vocali quasi inarrivabili.
Il disco, tuttavia, è ancora interlocutorio, tra il delicato cantautorato
tradizionale del precedente e le sperimentazioni funamboliche dei
successivi. Non mancano comunque capolavori, come la terza Love
from Room 109, un brano quasi da Goodbye and Hello ma trattato
e diversificato (dura più di dieci minuti) fino a farlo sembrare proto-progressive
(come del resto era la peraltro poco convincente title track dell’album
precedente). Dream Letter è un’assoluta perla di delicata
e devastante depressione, per xilofono e violoncello; da brividi.
L’ultima Sing a Song for You è ancora più delicata e dimessa
nelle sue fragili armonie, ma il capolavoro del disco è la penultima
e stranamente energica Gipsy Woman. La voce inizia in sordina,
ma poi il ritmo incalza, le percu
personaggio
selvaggiamente preda delle droghe. Le canzoni, ora solo sei, mantengono
più o meno la struttura tradizionale (country), ma gli arrangiamenti
si fanno più audaci e jazzati e due brani superano addirittura la
soglia dei 10 minuti. Anche la voce è diversa: ora sono gli shouter
neri i suoi maestri e Tim dimostra delle qualità vocali quasi inarrivabili.
Il disco, tuttavia, è ancora interlocutorio, tra il delicato cantautorato
tradizionale del precedente e le sperimentazioni funamboliche dei
successivi. Non mancano comunque capolavori, come la terza Love
from Room 109, un brano quasi da Goodbye and Hello ma trattato
e diversificato (dura più di dieci minuti) fino a farlo sembrare proto-progressive
(come del resto era la peraltro poco convincente title track dell’album
precedente). Dream Letter è un’assoluta perla di delicata
e devastante depressione, per xilofono e violoncello; da brividi.
L’ultima Sing a Song for You è ancora più delicata e dimessa
nelle sue fragili armonie, ma il capolavoro del disco è la penultima
e stranamente energica Gipsy Woman. La voce inizia in sordina,
ma poi il ritmo incalza, le percu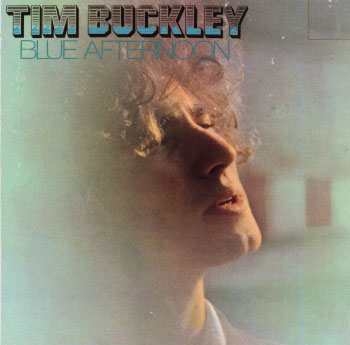 ssioni avvolgono e stimolano. E parte l’orgia,
tribale, irresistibile, colonna sonora di 12 minuti per danze selvagge
ed accoppiamenti bestiali.
ssioni avvolgono e stimolano. E parte l’orgia,
tribale, irresistibile, colonna sonora di 12 minuti per danze selvagge
ed accoppiamenti bestiali.
I tre dischi successivi sono altrettanti capolavori assoluti e la
loro descrizione richiederebbe troppo spazio. Lasciamo quindi al lettore
il piacere di assaporarseli poco a poco, alla scoperta di questo autentico
genio, tanto incompreso al suo tempo quanto immortale per i posteri,
dando di essi solo accenni sommari. L’amarezza estrema di Dream
Letter caratterizza quasi tutto Blue Afternoon (1969), dei tre
il più interessante per un pubblico dark, impregnato com’è del
pessimismo cosmico del suo autore. Tra i brani imperdibili I Must
have been Blind e Chase the Blues Away. L’effetto
della droga invece marchia indelebilmente Lorca: 5 lunghissime canzoni,
scale armoniche assurde ed innovative, tra il jazz e la sperimentazione,
con la voce a proporre i voli pindarici più azzardati (Buckley è stato
di sicuro il miglior cantante della sua epoca). Da segnalare, come
perla assoluta, la delirante Driftin’. Starsailor, infine,
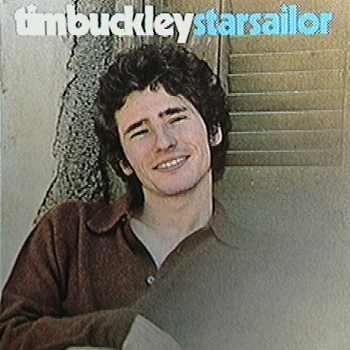 fu il passo estremo di una mente unica e devastata.
Sarabande soniche jazz e disarticolate, dissonanti e complesse, un
delirio cosmico e incompiuto della solitudine, poiché anche la sua
tragedia rimane incompiuta (come esempio si senta The Healing Festival).
La perla del disco, però, sarà una vecchia canzone del ’68, la
magica Song to the Siren.
fu il passo estremo di una mente unica e devastata.
Sarabande soniche jazz e disarticolate, dissonanti e complesse, un
delirio cosmico e incompiuto della solitudine, poiché anche la sua
tragedia rimane incompiuta (come esempio si senta The Healing Festival).
La perla del disco, però, sarà una vecchia canzone del ’68, la
magica Song to the Siren.
Poi fu il crollo. Due anni di riposo per tentare la disintossicazione,
un disco di assurdo e arrogante rhythm & blues (Greetings from
L.A., 1972), brutto ma sempre migliore delle due opere assolutamente
insulse che lo seguirono. E che anticiparono il suo suicidio per overdose,
a 28 anni, nella solitudine e nell’incomprensione più assoluta.
Cantante e musicista dotatissimo, Tim Buckley si è in qualche modo
presentato all’opposto del concittadino e contemporaneo Jim Morrison,
anch’egli tuttavia molto influenzato dal blues e da desueti registri
vocali: dove quello era pubblico, istrionico e sciamanico, lui fu
privato, schivo e mistico. Eppure anch’egli si calò (e con maggiori
capacità) nel nero più assoluto dell’anima umana. Purtroppo con
un pari, tragico epilogo.
indice
- avanti

 L’album
risultante, Songs of Leonard Cohen, del 1966, è un incredibile capolavoro.
Melodie delicatissime e toccanti, sarebbe meglio dire strazianti,
ma senza mai una traccia di lamentela o autocommiserazione. In compenso,
però, un pessimismo nero e depresso che impregna ogni cosa. La prima,
Suzanne, forse il capolavoro di Cohen, parla di una donna matta
eppur desiderata, di.un desiderio represso ed inconfessabile (you
touched her perfect body with your mind), accompagnato da lirica e
dolcissima depressione,
L’album
risultante, Songs of Leonard Cohen, del 1966, è un incredibile capolavoro.
Melodie delicatissime e toccanti, sarebbe meglio dire strazianti,
ma senza mai una traccia di lamentela o autocommiserazione. In compenso,
però, un pessimismo nero e depresso che impregna ogni cosa. La prima,
Suzanne, forse il capolavoro di Cohen, parla di una donna matta
eppur desiderata, di.un desiderio represso ed inconfessabile (you
touched her perfect body with your mind), accompagnato da lirica e
dolcissima depressione,  così come la lunga ed ipnotica The Stranger
Song. O ancora l’altrettanto lunga e commovente Sisters
of Mercy (nessun riferimento è casuale), dove viene mantenuta
fino in fondo l’ambiguità del nome, che può definire un ordine
religioso o in genere le prostitute. Più allegra ed arrangiata, So
Long Marianne precede l’altro capolavoro di depressa dolcezza
Hey, That’s no Way to Say Goodbye e l’anima sprofonda
fra pieghe segrete. L’autobiografica (come tutte, del resto)
Teachers contiene il famoso verso «some girls wander by mistake».
così come la lunga ed ipnotica The Stranger
Song. O ancora l’altrettanto lunga e commovente Sisters
of Mercy (nessun riferimento è casuale), dove viene mantenuta
fino in fondo l’ambiguità del nome, che può definire un ordine
religioso o in genere le prostitute. Più allegra ed arrangiata, So
Long Marianne precede l’altro capolavoro di depressa dolcezza
Hey, That’s no Way to Say Goodbye e l’anima sprofonda
fra pieghe segrete. L’autobiografica (come tutte, del resto)
Teachers contiene il famoso verso «some girls wander by mistake».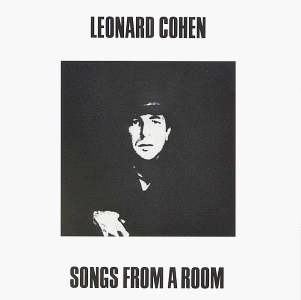 Piacevolmente sorpreso dall’insospettabile
successo internazionale del disco, tuttavia non più disposto di prima
a “darsi in pasto” a media e mondanità, Cohen ripeté la
stessa formula un anno dopo, dando alle stampe l’immortale Songs
from a Room. In effetti la formula è proprio la stessa (i due sono,
a tutti gli effetti, dischi gemelli), con aggiunta di spartanità per
la copertina in bianco e nero e di un’ulteriore dose di depressione.
Quello che purtroppo sembra mancare è l’incantevole magia delle
melodie, qui non meravigliosamente riuscite come nel titolo precedente.
Tuttavia non mancano i capolavori: una versione devastante di The
Partisan (con canto femminile in francese, da pelle d’oca),
unico brano non suo, lo sberleffo libertario di Bird on the Wire,
l’angoscia allucinante di Story of Isaac (il sacrificio
più famoso della Bibbia raccontato con gli occhi della vittima), la
pacata invettiva interpersonale di You Know Who I Am.
Piacevolmente sorpreso dall’insospettabile
successo internazionale del disco, tuttavia non più disposto di prima
a “darsi in pasto” a media e mondanità, Cohen ripeté la
stessa formula un anno dopo, dando alle stampe l’immortale Songs
from a Room. In effetti la formula è proprio la stessa (i due sono,
a tutti gli effetti, dischi gemelli), con aggiunta di spartanità per
la copertina in bianco e nero e di un’ulteriore dose di depressione.
Quello che purtroppo sembra mancare è l’incantevole magia delle
melodie, qui non meravigliosamente riuscite come nel titolo precedente.
Tuttavia non mancano i capolavori: una versione devastante di The
Partisan (con canto femminile in francese, da pelle d’oca),
unico brano non suo, lo sberleffo libertario di Bird on the Wire,
l’angoscia allucinante di Story of Isaac (il sacrificio
più famoso della Bibbia raccontato con gli occhi della vittima), la
pacata invettiva interpersonale di You Know Who I Am. Dopo il sentito live di rito, del
‘73, più convincente risulterà essere l’anno dopo New Skin
for the Old Ceremony. Le melodie si aprono ad atmosfere più aeree,
anche gli arrangiamenti risultano leggermente più vari. L’angoscia
di una vita di coppia vista come casa abitata da fantasmi in Is
This What you Wanted, ancora dolcezza dei primi tempi con Chelsea
Hotel #2, nuova energia con Lover Lover Lover, poi l’(auto)ironica
Field Commander Cohen, infine le bellissime There is a War
e Who by Fire. Copertina alchemica, melodie gaeliche, testi
importanti, una voce che cominciava a scaldarsi e che, con gli anni,
avrebbe portato Cohen ad interpretare le tonalità più basse e profonde
del cantautorato internazionale.
Dopo il sentito live di rito, del
‘73, più convincente risulterà essere l’anno dopo New Skin
for the Old Ceremony. Le melodie si aprono ad atmosfere più aeree,
anche gli arrangiamenti risultano leggermente più vari. L’angoscia
di una vita di coppia vista come casa abitata da fantasmi in Is
This What you Wanted, ancora dolcezza dei primi tempi con Chelsea
Hotel #2, nuova energia con Lover Lover Lover, poi l’(auto)ironica
Field Commander Cohen, infine le bellissime There is a War
e Who by Fire. Copertina alchemica, melodie gaeliche, testi
importanti, una voce che cominciava a scaldarsi e che, con gli anni,
avrebbe portato Cohen ad interpretare le tonalità più basse e profonde
del cantautorato internazionale. dalla
personalità molto più fragile, Nick Drake fu autore di tre bellissimi
dischi fra il ‘69 ed il ‘72. Inglese, nato a Burma, studentello
a Cambridge, con il primo Lp, Five Leaves Left, si inserì nel filone
allora di grido del folk revival. Le sue carte emergono sin da subito,
in tutto il loro splendore: una voce tenue e delicata, ma incredibilmente
matura, a comporre acquarelli intimi e fatalisti. Spesso una disincantata
depressione fa capolino tra queste perle diafane, rendendole vibranti
fino ai brividi. È il caso di Three Hours o di Cello Song,
dalla
personalità molto più fragile, Nick Drake fu autore di tre bellissimi
dischi fra il ‘69 ed il ‘72. Inglese, nato a Burma, studentello
a Cambridge, con il primo Lp, Five Leaves Left, si inserì nel filone
allora di grido del folk revival. Le sue carte emergono sin da subito,
in tutto il loro splendore: una voce tenue e delicata, ma incredibilmente
matura, a comporre acquarelli intimi e fatalisti. Spesso una disincantata
depressione fa capolino tra queste perle diafane, rendendole vibranti
fino ai brividi. È il caso di Three Hours o di Cello Song,
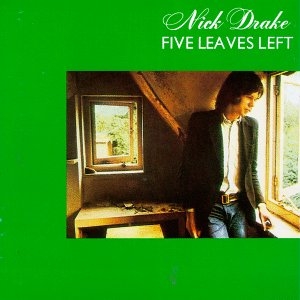 mentre brani come Way to Blue o Fruit
Tree mettono in luce addirittura una sorta di pessimismo cosmico,
alla Tim Buckley. Un caso a parte lo costituisce la splendida River
Man, trascendente e psichica, cosmica ed onirica fino all’alienazione.
mentre brani come Way to Blue o Fruit
Tree mettono in luce addirittura una sorta di pessimismo cosmico,
alla Tim Buckley. Un caso a parte lo costituisce la splendida River
Man, trascendente e psichica, cosmica ed onirica fino all’alienazione. Poi qualcosa successe nella vita di Nick Drake.
Un travaglio esistenziale devastante, che l’ha portato sull’orlo
di una depressione senza ritorno. Molte canzoni, brevissime, furono
composto in questo periodo; quasi non arrangiate, giusto una chitarra
classica ed un piano. Undici di queste andarono a comporre il suo
ultimo album, il breve Pink Moon, del ’72. Sono i brani più scarni
e belli del genere a comporre questo capolavoro di depressione cosmica:
la title-track, Road, Which Will, Know, Parasite.
Ballate catatoniche ed attonite, di una dolcezza struggente, di un
pessimismo sconsolato e schiacciante. Fino alla “parabola terrificante
sulla solitudine in mezzo alla folla” (così lo Scaruffi) di Things
Behind the Sun, dove il punto di non ritorno viene ampi
Poi qualcosa successe nella vita di Nick Drake.
Un travaglio esistenziale devastante, che l’ha portato sull’orlo
di una depressione senza ritorno. Molte canzoni, brevissime, furono
composto in questo periodo; quasi non arrangiate, giusto una chitarra
classica ed un piano. Undici di queste andarono a comporre il suo
ultimo album, il breve Pink Moon, del ’72. Sono i brani più scarni
e belli del genere a comporre questo capolavoro di depressione cosmica:
la title-track, Road, Which Will, Know, Parasite.
Ballate catatoniche ed attonite, di una dolcezza struggente, di un
pessimismo sconsolato e schiacciante. Fino alla “parabola terrificante
sulla solitudine in mezzo alla folla” (così lo Scaruffi) di Things
Behind the Sun, dove il punto di non ritorno viene ampi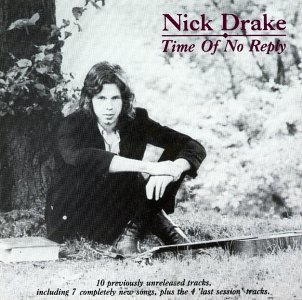 amente superato.
amente superato.
 personaggio
selvaggiamente preda delle droghe. Le canzoni, ora solo sei, mantengono
più o meno la struttura tradizionale (country), ma gli arrangiamenti
si fanno più audaci e jazzati e due brani superano addirittura la
soglia dei 10 minuti. Anche la voce è diversa: ora sono gli shouter
neri i suoi maestri e Tim dimostra delle qualità vocali quasi inarrivabili.
Il disco, tuttavia, è ancora interlocutorio, tra il delicato cantautorato
tradizionale del precedente e le sperimentazioni funamboliche dei
successivi. Non mancano comunque capolavori, come la terza Love
from Room 109, un brano quasi da Goodbye and Hello ma trattato
e diversificato (dura più di dieci minuti) fino a farlo sembrare proto-progressive
(come del resto era la peraltro poco convincente title track dell’album
precedente). Dream Letter è un’assoluta perla di delicata
e devastante depressione, per xilofono e violoncello; da brividi.
L’ultima Sing a Song for You è ancora più delicata e dimessa
nelle sue fragili armonie, ma il capolavoro del disco è la penultima
e stranamente energica Gipsy Woman. La voce inizia in sordina,
ma poi il ritmo incalza, le percu
personaggio
selvaggiamente preda delle droghe. Le canzoni, ora solo sei, mantengono
più o meno la struttura tradizionale (country), ma gli arrangiamenti
si fanno più audaci e jazzati e due brani superano addirittura la
soglia dei 10 minuti. Anche la voce è diversa: ora sono gli shouter
neri i suoi maestri e Tim dimostra delle qualità vocali quasi inarrivabili.
Il disco, tuttavia, è ancora interlocutorio, tra il delicato cantautorato
tradizionale del precedente e le sperimentazioni funamboliche dei
successivi. Non mancano comunque capolavori, come la terza Love
from Room 109, un brano quasi da Goodbye and Hello ma trattato
e diversificato (dura più di dieci minuti) fino a farlo sembrare proto-progressive
(come del resto era la peraltro poco convincente title track dell’album
precedente). Dream Letter è un’assoluta perla di delicata
e devastante depressione, per xilofono e violoncello; da brividi.
L’ultima Sing a Song for You è ancora più delicata e dimessa
nelle sue fragili armonie, ma il capolavoro del disco è la penultima
e stranamente energica Gipsy Woman. La voce inizia in sordina,
ma poi il ritmo incalza, le percu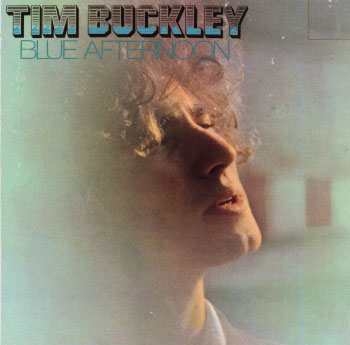 ssioni avvolgono e stimolano. E parte l’orgia,
tribale, irresistibile, colonna sonora di 12 minuti per danze selvagge
ed accoppiamenti bestiali.
ssioni avvolgono e stimolano. E parte l’orgia,
tribale, irresistibile, colonna sonora di 12 minuti per danze selvagge
ed accoppiamenti bestiali.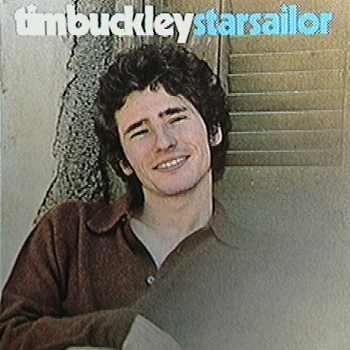 fu il passo estremo di una mente unica e devastata.
Sarabande soniche jazz e disarticolate, dissonanti e complesse, un
delirio cosmico e incompiuto della solitudine, poiché anche la sua
tragedia rimane incompiuta (come esempio si senta The Healing Festival).
La perla del disco, però, sarà una vecchia canzone del ’68, la
magica Song to the Siren.
fu il passo estremo di una mente unica e devastata.
Sarabande soniche jazz e disarticolate, dissonanti e complesse, un
delirio cosmico e incompiuto della solitudine, poiché anche la sua
tragedia rimane incompiuta (come esempio si senta The Healing Festival).
La perla del disco, però, sarà una vecchia canzone del ’68, la
magica Song to the Siren.