|
THE CURE
live
@ Wembley
Arena,
London
11, 12 e 13 Dicembre 2022
Testo e
fotografie di Gianmario Mattacheo
…
Primo atto
(1/3).
11
dicembre 2022
Arrivati quasi alla
conclusione di questo tour, mi permetto, almeno
una volta, di non scrivere una recensione, ma di
giocare con una serie di lettere e nomi che ci
frullano in testa in questa nostra passione.
L come Londra, allora,
perché qui mancavo dal 2018, quando i Cure
festeggiavano i loro primi quarant’anni.
W come la Wembley Arena,
ovvero una delle arene più prestigiose della City
(e con la data del 13 dicembre saranno 7 le volte
in cui ho visto qui la banda Smith).
A come “Alone”, ovvero
l’apripista di ogni concerto targato 2022, ma
anche A come “And nothing is forever”, perché
niente mi ha mai toccato così nel profondo.
B come “Burn”, così
tornando a casa mi riguardo il “Il corvo”.
I come Inbetween days,
perché non c’è festa senza quel pop di “The head
on the door”.
O come “One hundred years”
perchè una volta si diceva che non “Importa se
moriamo tutti”.
La N per le notti di “At
night” e di “A night like this” (nonostante
l’assolo di Gabrels, per il quale si potrebbe
individuare una nuova fattispecie di reato:
vilipendio alla canzone).
P per “Play for today” e
“Push” con le loro immancabili partecipazioni del
pubblico.
C per “Cold” e che bello è
stato il suo ripescaggio in questo tour.
La F di “A forest”, perché
se c’è un inno in assoluto è proprio questa
canzone.
Ancora la F. Questa è di
“Faith”, canzone che conosce pochi rivali,
soprattutto del primo periodo.
H per il paradiso di “Just
like heaven”.
C per “Charlotte
sometimes”, un evergreen come nelle vecchie serate
dark.
E per “Endsong” e giù
lacrime senza ritegno.
La I per “I can never say
goodbye” perché l’amore per un fratello non ha
ter mini di paragone e mai si pronuncerà la parola
addio. mini di paragone e mai si pronuncerà la parola
addio.
“M” per la consorte Mary,
presente e partecipativa ai lati del palco, qui a
Wembley. Ma M sta anche per Moglie (la mia in
questo caso), per l’immancabile e prezioso
supporto.
P per pubblico o P per
popolo, è uguale. Quello dei Cure.
6 come i Cure che stanno
sul palco (bentornato Perry, qualunque sia il tuo
futuro in seno alla band, ti auguriamo il meglio).
46 per i concerti di questo “Shows of a lost world
tour”.
B per il “Bad Wolf” di
Simon, l’alfiere più importante della scacchiera
di Robert. Che la tua calzamaglia possa continuare
a ballare per il palco ancora per molto tempo.
R per Robert, e chi se non
lui. Perché, diversamente, proprio non si può
terminare.
… Secondo atto
(2/3)
12 dicembre 2022
Penultimo capitolo di
questo “Shows of a lost world tour” e ci
ritroviamo ancora alla Wembley Arena, ormai mitico
luogo in cui i Cure sono soliti chiudere le
proprie fatiche concertistiche, dopo un lungo ed
estenuante peregrinare per tutta l’Europa.
Forse il botto emotivo ci
colpirà ancora di più domani, ma non nascondiamo
che un inizio di malinconia sembra iniziare a
bussare alla nostra porta; ci penseremo a tempo
debito. Ora è il momento per un po’ di cronaca.
Vociare del pubblico
sempre più insistente, poi un rumore di tuoni,
unito ad alcuni lampi, anticipa l’ingresso sul
palco dei musicisti e, mentre partono le prime
note del concerto, il cielo stellato ci porta
immediatamente dentro lo show. “Questa è la fine”
canta Robert nell’incipit di “Alone”, anche se è
l’inizio di un’altra favolosa avventura, lunga la
bellezza di 28 canzoni.
Nella prima porzione del
concerto “At night” avvolge tutta la Wembley Arena
di un’atmosfera magica che, subito dopo, continua
con il classicone dark di “Charlotte sometimes”.
Sono due canzoni che segnano la strada di un
intero concerto.
“Burn”, dopo tanti anni di
silenzio, è da qualche stagione un classico
irrinunciabile del gruppo, così come il siparietto
in cui Robert si appoggia su Simon, schiena a
schiena in un momento di preziosa complicità.
“The figurehead” e “A
strange day” sono perfettamente eseguite e
continuano a trasportarci nel clima di un concerto
nato per scatenare emozioni tanto forti quanto
intime, invece “Push”, “Play for today” e “Shake
dog shake” hanno il compito di far virare il
concerto sul ritmo, sulla forza e sulla
partecipazione collettiva, attraverso un piglio
incredibile e una potenza sonica difficile da
eguagliare.
Parte del leone per
l’album “Disisntegration” con 6 pezzi, seguito da
“The head on the door” con 4 e “Seventeen seconds”
con 3, mentre rimangono ancora al palo gli ultimi
due in studio, a testimoniare come siano
indubbiamente i capitoli meno felici del gruppo.
Quando arriva l’ultima canzone del mainset, non
possiamo rimanere insensibili alle parole
contenute in “Endsong”: “È tutto finito, è tutto
finito, Non è rimasto niente di tutto ciò che ho
amato, Sembra tutto sbagliato, È tutto finito, è
tutto finito, è tutto finito,Nessuna speranza,
nessun sogno, nessun mondo”.
Il primo encore è sempre
il più atteso. Alla dedica al fratello, segue un
vero e proprio tributo all’ineguagliabile album
del 1989. Finalmente, riesco a sentire “Plainsong”
quest’anno e, anche se rende esponenzialmente di
più quando è presentata come apripista dei
concerti, conserva intatte tutte le sue dolci
qualità. Poi Robert Smith ci fa vedere quanto
voglia portare al limite le sue capacità vocali,
prima con “Prayers for rain” e poi con
“Disintegration”. Con la prima, non giocando per
nulla al risparmio, concede un acuto esattamente
speculare alla versione live del 1989 (riascoltare
“Entreat”) e, con la canzone che titolava
quell’album, finisce senza un briciolo di energie.
Solo in parte i segni
dell’età suggeriscono, anche a noi, quanto il
concerto stia volgendo al termine, perché, quelle
due ore e mezza, sono volate, in effetti, a
velocità quadrupla rispetto al normale corso di un
orologio.
Ma, come da copione, la
band non si fa mancare l’ultimo rientro; quello
che si definisce pop potrebbe (erroneamente)
essere letto in senso dequalificante, quando, in
realtà, rappresenta una delle tante facce che
Robert Smith ha splendidamente assunto in più di
quaranta anni di carriera. E, allora, ci sono
“Lullaby” (che io spero sempre non faccia), c’è il
funky elettronico di “The walk”, c’è la “Friday”
che quest’anno è diventata una splendida
trentenne, e ci sono le altre, fino a “Boys don’t
cry”.
Lui alla fine sorride e
dice “See you again” e allora perché piangere,
dopotutto?
… to be continued
…
terzo atto (3/3)
13 dicembre
2022
Eccolo arrivato, il
quarantaseiesimo concerto, tappa finale di un tour
sorprendentemente forte ed emotivo come mai in
passato i Cure erano riusciti a porre in essere.
Ad anticipare i nostri,
ancora una volta i Twilight Sad
(a conti fatti,
ormai uno dei gruppi che ho visto di più nella mia
carriera di guardone rock!) e dopo l’ultima
sviolinata da parte di James Graham, inizia
l’ultimo rituale dei roadie, per preparare il
campo ai cinque musicisti agli ordini di Robert
Smith.

Ad ogni canzone parte la
solita partecipazione, accompagnata, questa volta,
ad alcuni flash con i quali vogliamo fissare nella
memoria attimi e frammenti di un intero tour.
Così, per esempio, sono
certo che mi ricorderò di “Pictures of you” non
solo per quel duetto con Simon Gallup (un po’ da
cliché ma che piace tanto a tutti), ma anche per
quell’abbraccio che Robert riserva alla sua
chitarra, compagna di vita fedele e quasi una
prolunga delle sue braccia.
“Ci provo a non
commuovermi questa volta”, mi dico, quando parte
l’intro di “And nothing is forever”. Ma, anche
oggi, l’impresa risulta vana, mentre partono le
note pennellate da O’Donnell, sai già che quelle
parole faranno ancora breccia in te … e
chissenefrega del vicino, è anche il mio momento
questo, lasciatemi godere e piangere allo stesso
tempo.
Come ormai sappiamo, il
mainset si chiude con due canzoni in cui le
chitarre la fanno da padrone. Con “From the edge
of the deep green sea”, è proprio Robert Smith a
ribadire il concetto, quando afferma (nel recente
booklet della deluxe edition di “Wish”): “E’ una
canzone piuttosto delirante, e senza dubbio il mio
miglior momento da aspirante Hendrix”. “Endsong”,
invece, è una suite che cresce piano piano, per
accompagnare il dolore del suo autore. autore.
Al rientro, quando Robert
canta l’amore per il fratello, sembra che l’intera
Wembley Arena si ghiacci di fronte alla sua
espressività. Poi, arriva la prima sorpresa del
tour con “Three imaginary boys” e le luci ad
illuminare i soli Smith, Gallup e Cooper. A
confermare quanto il primo dei rientri sia forse
quello dal più alto valore artistico, arriva una
versione da urlo di “One hundred years”, una
“Primary” (singolo dell’album “Faith”) e “A
forest”, chiusa da un rabbioso Simon, mentre
percuote e violenta il proprio basso elettrico.
Rientrato in scena per
l’ultimo encore, Robert Smith ha parole di
ringraziamento un po’ per tutti, da Twilight Sad,
fino ad arrivare a chi con tanta passione l’ha
seguito fino a questo punto.
Ad un copione che pare
ricalcare il classico rientro pop (con l’aggiunta
di una “Doing the unstuck” non eseguita proprio al
massimo), il capobanda vuole fare l’ultima
sorpresona di fine tour. Così, dopo “Boys don’t
cry”, si rimane sul palco, mentre inizia a perdere
il rubinetto di “10.15 Saturday night” che lascia
il posto alla miglior conclusione possibile. Quando la chitarra di Robert Smith scandisce le
note di “Killing an arab”, la platea diventa
un’onda in movimento in cui rimanere in piedi non
è proprio la cosa più facile del mondo, ma che,
tuttavia, non impedisce a ciascuno di noi di
cantare le parole del primo singolo del gruppo.
Quando la chitarra di Robert Smith scandisce le
note di “Killing an arab”, la platea diventa
un’onda in movimento in cui rimanere in piedi non
è proprio la cosa più facile del mondo, ma che,
tuttavia, non impedisce a ciascuno di noi di
cantare le parole del primo singolo del gruppo.
Concludiamo anche questo
tour. Un tour che abbiamo così tanto desiderato da
viverlo con ancor più intensità rispetto al
passato. E di intensità ne abbiamo proprio presa
tanta, perché ci sono state tante di quelle cose
che, si sa, le recensioni solo in piccola parte
possono cogliere. Pensando (e rileggendo) le mie
considerazioni finali dell’ultimo tour (2019), mi
accorgo quanto quello finito da sole poche ore sia
stato, in effetti, molto diverso. Tanto il
precedente viveva di un contagioso buon umore,
quanto questo ha scavato intimamente nell’animo di
tutti. Non abbiamo più i vent’anni spensierati e
il tempo ha segnato cicatrici che anche lo
specchio più gentile non può camuffare. Ecco,
ascoltando le parole delle nuovissime canzoni di
Robert Smith siamo sempre più convinti di questo
e, mai come in passato, quel signore in nero ha
scavato dentro i nostri più intimi sentimenti e lo
ha fatto mostrandosi nudo di fronte ai sui fan.
Fragilità; è questa una parola che legherei
(molto) ai concerti di quest’anno. Spiattellando
il dolore, la constatazione del passaggio del
tempo, la paura del futuro, Robert Smith ha
trovato la chiave per aprire il suo ed il nostro
cuore e, facendolo, ha cementato ancora di più
quell’indissolubile catena che ci tiene fedelmente
ancorati a lui.
| Foto del
12 Dicembre |
|
 |
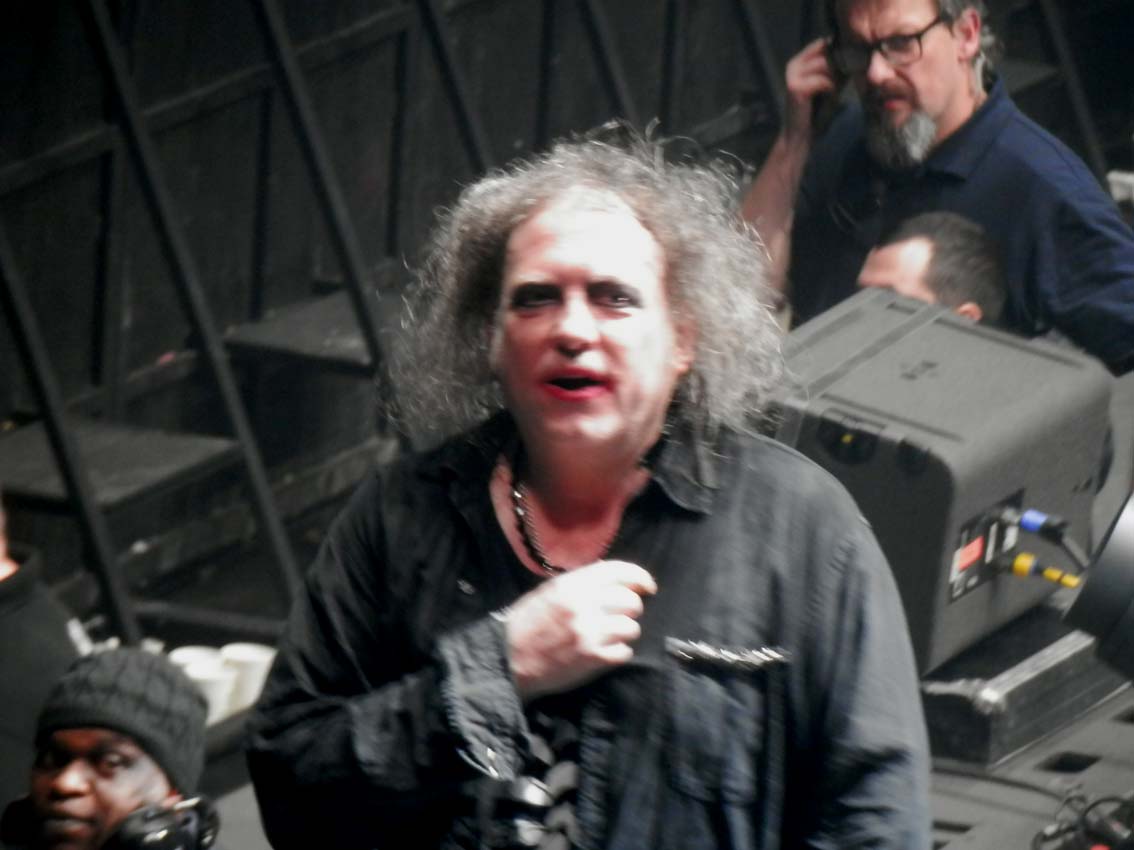 |
 |
 |
 |
 |
|
Foto
del 13 Dicembre |
|
 |
 |
 |
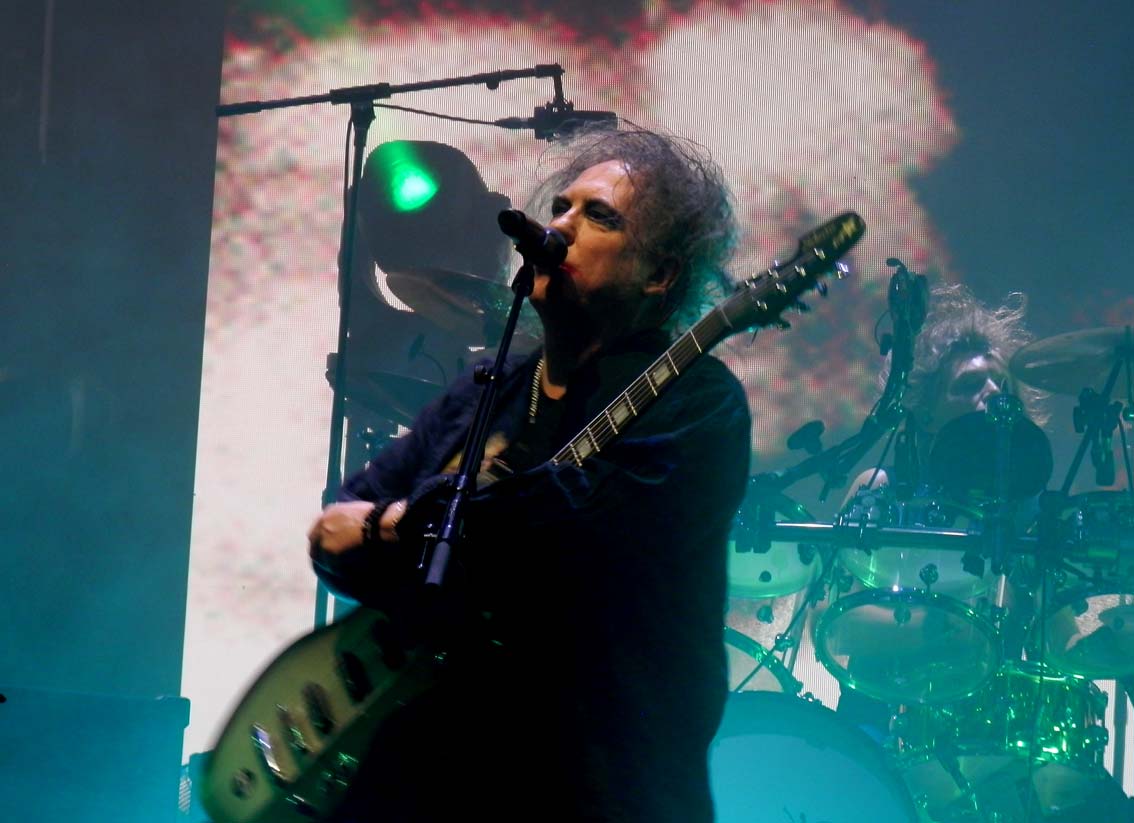 |
|