LEONARD
COHEN
@
piazza San Marco, Venezia, 3 agosto 2009.
testo
by Gianmario Mattacheo
Quando
ci si appresta a vedere un concerto di un signore che ha raggiunto
le settantacinque primavere, non ci si siede con la convinzione
di assistere ad uno spettacolo live di grande intensità
e di straordinaria lunghezza; più semplicemente, ci
si muove per poter dire un giorno “Ho visto suonare Leonard
Cohen”, e poco altro.
Già,
perché l’artista di cui stiamo parlando è proprio
uno di quei nomi che più hanno influenzato le molti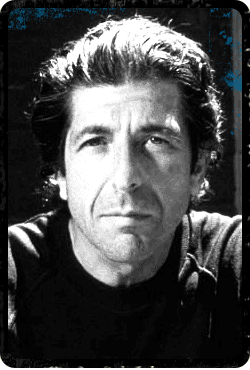 ssime
generazioni di musicisti (tuttora presenti, o già passati),
divenuti, a loro volta, icone musicali.
ssime
generazioni di musicisti (tuttora presenti, o già passati),
divenuti, a loro volta, icone musicali.
Cohen,
come risaputo, si presenta prima come poeta che come musicista;
prima come paroliere solitario che compositore od intrattenitore.
All’attivo,
infatti, può vantare solo una decina di album (inclusi
i live). Lavori che, comunque, hanno segnato in maniera indissolubile
la storia della musica.
L’appuntamento
di questa sera, per tutti questi motivi, è uno di quelli
a cui non ci sentiamo di rispondere negativamente e (a dire
la verità) senza troppe pretese, ci dirigiamo in una
delle piazze più belle e visitate del mondo.
Piazza
San Marco non ha proprio bisogno di presentazioni e neppure
di essere celebrata in questa recensione. Qui possiamo solo
aggiungere che la sua cornice toglie il fiato per la bellezza:
il campanile di San Marco, la Basilica e gli imponenti portici
sono già un ottimo regalo per chi ha deciso di passare
un po’ di tempo in compagnia del cantautore canadese.
Si
teme, in realtà, una serata disastrosa, se non altro
per le condizioni climatiche che hanno “regalato” una pioggia
piuttosto insistente per tutto il pomeriggio. Per fortuna,
le precipitazioni iniziano a cessare poco prima delle 21.30,
orario previsto per l’inizio dello spettacolo.
Il
palco, posto esattamente di fronte alla Basilica, è
pronto per l’ingresso dei musicisti che (con puntualità)
entrano in fila indiana, omaggiati dall’applauso di una Piazza
San Marco quasi piena.
Cohen
è l’ultimo ad entrare. È elegantissimo nel suo
abito scuro e nel suo cappello che toglierà solo per
salutare il pubblico o per omaggiare i suoi compagni d’avventura.
La
musica di Cohen non richiede musicisti virtuosi. Tuttavia
tutti e nove gli strumentisti ci sembrano ottimi esecutori,
perfetti nell’entrare in scena senza prevaricare l’altro e
senza soffocare la voce del vecchio cantante.
Sharon
Robinson è presentata da Cohen come la coautrice delle
sue canzoni. La sua voce è potente e melodica, mentre
incanta con i cori la platea veneziana. Javier Mas (chitarre,
mandolini, liuti) viene più volte omaggiato da Leonard
Cohen (che si inginocchia più volte al suo cospetto,
mentre lo spagnolo esegue gli assoli).
Neil
Larsen (tastiere), Bob Metzger (chitarre), Rafael Bernardo
Gayol (batteria), Rosco Beck (basso), e le sorelle Webb (cori)
svolgono un compito assolutamente non virtuoso, ma preciso
e fondamentale.
E
poi c’è soprattutto quella voce roca, bassa e leggermente
malinconica.
Proprio
quella voce è uno dei principali marchi di fabbrica
del Cohen cantante.
Ci
sono alcuni artisti con corde vocali così basse che
sembra che tirino fuori la voce da chissà dove: Capitan
Beefheart, Tom Waits, Nick Cave, Mark Lanegan (più
recentemente), cantanti che hanno ricevuto un dono (in alcuni
casi aiutato dalla troppa nicotina respirata) tale da far
apparire il discorso musicale come secondario, rispetto a
quello più prettamente canoro.
Tutti
questi artisti, probabilmente, devono parte della loro nascita
musicale a questo ebreo trapiantato in terra canadese, tanti
anni fa.
E
poi arrivano le canzoni. Nessun brano, tra quelli più
celebri, è trascurato.
Cohen,
tra un pezzo e l’altro ringrazia il pubblico e gli fa i complimenti
per aver affrontato la pioggia; non manca di ringraziare i
musicisti sul palco (sono almeno due le presentazioni che
fa per tutta l’intera band) e compie, tra un’uscita e l’altra,
alcuni balletti che ci fanno vedere un menestrello felice
e sereno mentre compie allegramente il suo lavoro.
La
band non si risparmia in assoli quando il vecchio cantante
cita per l’ennesima volta il nome dei protagonisti (è
curioso vedere Gayol che perde le bacchette proprio quando
il suo assolo di batteria volge verso il termine) ed è
piacevole vedere i balletti delle sorelle Webb (che Cohen
definisce anche ginnaste!).
“Dance
me to the end of love” e “The future” (che ci riporta alla
memoria il bellissimo film di Oliver Stone “Natural born killers”)
hanno l’onere di aprire la serata.
Ma
poi anche “Tower of song”, “I’m your man” ed “Everybody knows”.
“Closing
time” è una delle esecuzioni più toccanti, mentre
“First we take Manhattan” è quella che ritma maggiormente
il concerto.
“So
long Marianne” è accolta da un boato e “Suzanne” è
il cavallo di battaglia del canadese (inutile dire che il
pubblico si esalta).
Con
“Hallelujah” arriva un’altra popolarissima canzone, resa ancor
più famosa dalle importanti cover (su tutte quella
di Jeff Buckley).
Quando
per l’ennesima volta Cohen torna sul palco, sembra voler dichiarare
al pubblico la sua intenzione di continuare la festa e, proprio
per questo, intona “I tried to leave you” (appunto “provai
a lasciarti”) ed il pubblico sorride divertito.
Quando
finalmente arriva l’ultimo saluto, tutto il pubblico è
in piedi per applaudire questo 75enne che, in effetti, non
ha età; semplicemente un uomo che ha saputo realizzare
un concerto di quasi tre ore, tra sussurri profondi, note
malinconiche ed una grande saggezza.